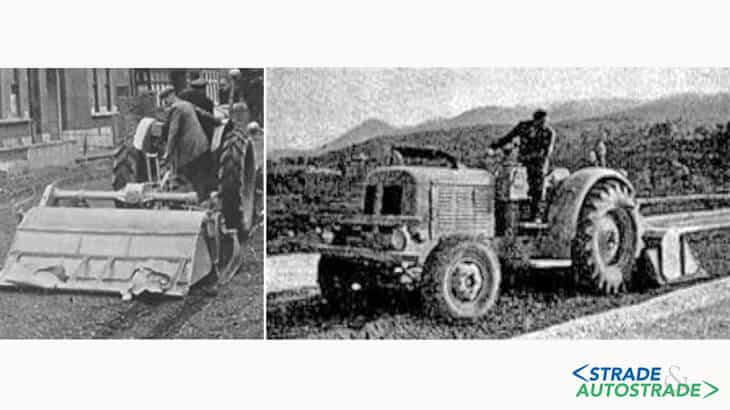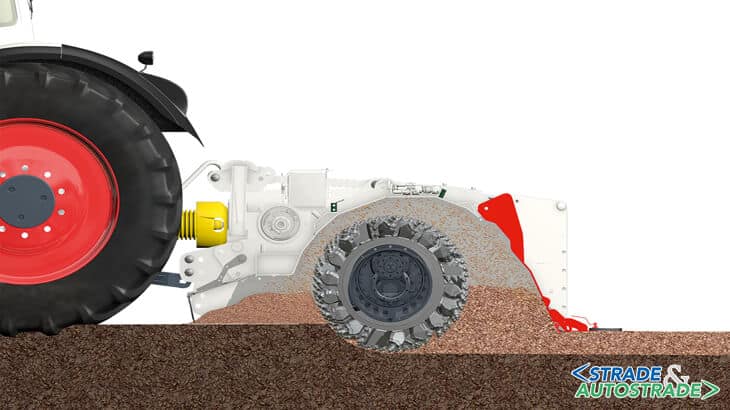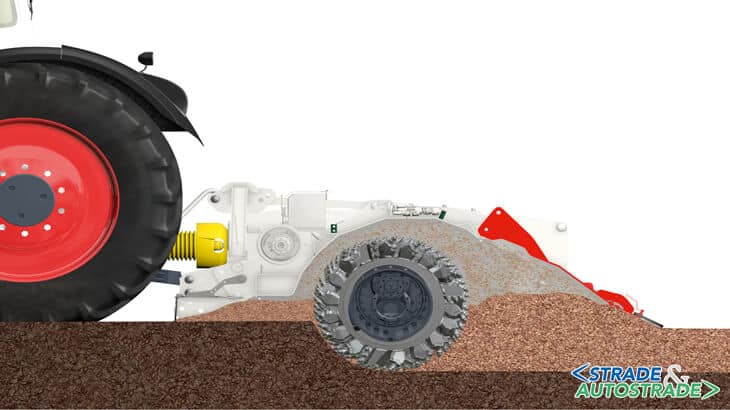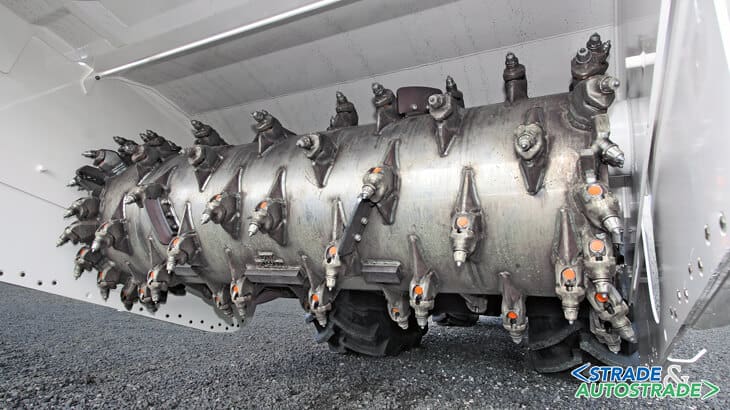Dagli anni Novanta le grandi opere, Alta Velocità in primis, hanno visto lo spiegamento talvolta importante di stabilizzatrici semoventi di tutte le taglie, con picchi nel numero di unità unici in Europa; ciò a giusta ragione, viste le grandi quantità e le produzioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di progetto.
Questa riscoperta della tecnologia faceva seguito ad un periodo di quasi oblio, dopo un precedente periodo di interesse che sfumò poi in parte per ragioni di contesto economico e in parte a causa di alcune mediocri esecuzioni. A titolo di testimonianza storica di quel primo periodo, è peraltro interessante notare che una macchina trainata, come una miscelatrice, già alla fine degli anni Cinquanta fosse utilizzata nei lavori per la realizzazione della diga sul torrente Aia in Umbria.
Il “rinascimento” della stabilizzazione ha sancito definitivamente che la stabilizzazione delle terre – se applicata con cognizione e a regola d’arte – è, a tutto diritto, una tecnologia vincente. Sulla tecnologia in sé dunque vi è poco da aggiungere; sulla progettazione delle miscele, sui controlli e sull’operatività di cantiere nulla di nuovo, visto che sono stati scritti interi volumi e fiumi di articoli. Pertanto, stupisce che dopo molti anni di importanti esperienze e risultati consolidati ancora localmente si trovi qualche sacca di non conoscenza della tecnologia o, peggio, qualche resistenza tecnica a priori.
La memoria breve è però ancora ancorata alla stabilizzazione di grandi volumi e dunque l’unico aspetto cui un breve articolo può dare ancora valore è piuttosto una riflessione sullo spettro potenziale di impiego della stabilizzazione.